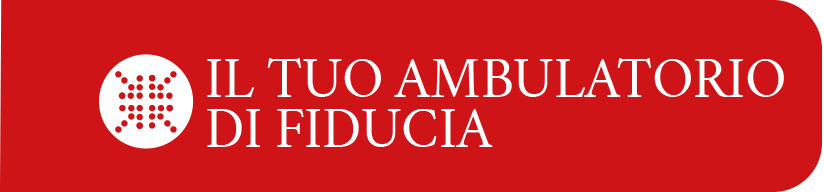
Il ferro è un microelemento indispensabile per l’organismo umano (e per quasi tutti gli esseri viventi) poiché è il principale minerale coinvolto in processi vitali di trasporto dell’ossigeno in tutti i tessuti ed organi del corpo, di reazioni di ossido-riduzione (trasferimento di elettroni), di sintesi degli acidi nucleici.
Il ferro è presente sotto forma di ione metallico all’interno della struttura di proteine e di complessi molecolari come enzimi e cofattori energetici; complessivamente, nel corpo umano la quantità totale di ferro è di circa 4-5g, quantità mantenuta in stretto equilibrio dinamico tramite raffinati meccanismi di regolazione omeostatici poiché le variazioni sia in negativo (deficit) che in positivo (eccesso) hanno importanti conseguenze fisiologiche.
La distribuzione del ferro nell’organismo
All’interno dei complessi molecolari di cui fa parte, lo ione ferro può avere due valenze: ione ferroso Fe2+ e ione ferrico Fe3+.
Lo ione ferroso Fe2+ (forma ridotta, che può donare elettroni) si trova
— nella composizione di complessi e strutture proteiche (proteine contenenti gruppi ferro-zolfo)
— legato in posizione centrale all’interno di una struttura molecolare prostetica detta eme, a sua volta componente delle proteine deputate al trasporto dell’ossigeno (emoglobina, mioglobina) ; solo in questa forma, il ferro è capace di legare ossigeno
Lo ione ferrico Fe3+ (forma ossidata, che può acquisire elettroni) si trova
— nella composizione di complessi molecolari e strutture proteiche (enzimi e proteine contenenti gruppi ferro-zolfo)
— legato all’interno delle proteine di deposito, come la ferritina e l’emosiderina; piccole quantità (circa 0.5%) di ferro non-emico si trovano anche legate all’interno di enzimi mitocondriali come le deidrogenasi, la catalasi o le perossidasi, e della transferrina, la sua principale proteina di trasporto.
L’importanza dello ione ferro nel nostro organismo è dettata proprio dalla sua capacità di ricevere e donare elettroni: i processi di trasferimento di elettroni stanno alla base di tutti i meccanismi vitali cellulari (respirazione cellulare e rifornimento energetico, divisione differenziazione e crescita cellulare, rinnovo delle sequenze di acidi nucleici e tanto altro).
Trasporto dell’ossigeno
Il ruolo più conosciuto del ferro all’interno del corpo umano è quello del fissaggio e trasporto dell’ossigeno in tutti i tessuti ed organi: tramite l’emoglobina per tutti i distretti del corpo, e tramite la mioglobina, per immagazzinare il ferro a livello del muscolo.
Respirazione cellulare
La produzione di energia nelle cellule ha luogo attraverso una catena di reazioni in cui si sintetizza ATP (Adenosin-trifosfato, utilizzato in seguito come fonte di energia), catena che porta il nome di ‘’respirazione cellulare’’ (più precisamente, i processi biochimici della fosforilazione ossidativa, nei mitocondri); queste reazioni si svolgono con l’impiego di complessi molecolari proteici, alcuni contenenti ferro-eme; ed altri – centri ferro-zolfo (proteine, enzimi, citocromi Eme A, B, C).
Queste reazioni avvengono nei mitocondri (organelli residenti nel citoplasma delle cellule, dotati di DNA proprio e sedi della produzione di energia); un mitocondrio può avere più di 10mila sistemi di trasferimento di elettroni e di molecole di ATPsintasi.
Centri Ferro ‐ Zolfo
I gruppi ferro-zolfo (o centri Fe-S) nella struttura di una proteina, sono gruppi prostetici contenenti ferro legato allo zolfo inorganico ed organico (nel residuo di cisteina nella proteina); il ferro si può trovare sia come Fe2+ che Fe3+: in realtà, le reazioni di ossido-riduzione sono molto rapide ed a doppio senso, facendo sì che lo ione possa passare velocemente da uno stato all’altro in funzione della richiesta energetica cellulare.
Risposta immunologica e difese immunitarie
Il ferro è vitale per
La capacità ossido-riduttiva del ferro ne detta anche la potenzialità tossica per le cellule, dato che i meccanismi di bilancio delle forme ridotta ed ossidata del ferro nei suoi composti ordinano anche la produzione di radicali liberi dell’ossigeno (ROS); questi meccanismi sono finemente e rigorosamente controllati proprio per mantenere in equilibrio la produzione e utilizzo cellulare dei ROS.
Il fabbisogno giornaliero di ferro viene ordinato in maniera massiccia dalla distruzione degli eritrociti invecchiati e danneggiati (senescenti); e in maniera minore dall’introduzione con il cibo.
Il ferro introdotto con gli alimenti può essere ferro-eme, che si trova principalmente nei cibi di origine animale (carni); e ferro non-eme, sotto forma di sali inorganici (apportanti sia Fe2+ che Fe3+), soprattutto negli alimenti di origine vegetale.
La forma maggiormente assorbibile è quella Fe2+, mentre la forma Fe3+ deve prima subire la reazione di riduzione alla forma Fe2+ per essere assorbita.
Durante il passaggio nello stomaco, il Fe3+ alimentare viene liberato dalle molecole proteiche e ridotto a Fe2+ sotto l’azione congiunta dell’acido cloridrico e della pepsina (enzima gastrico deputato alla digestione delle proteine).
L’assorbimento del ferro avviene principalmente nel duodeno; nelle cellule della mucosa intestinale il Fe2+ è ossidato a Fe3+: parte di esso viene legato alla transferrina che lo porta nel circolo ematico; il resto viene immagazzinato nelle proteine di deposito, la ferritina e l’emosiderina, e trasportato negli organi preposti (fegato, milza, midollo osseo, muscolo scheletrico).
In base al fabbisogno, il ferro viene liberato dai depositi, ossidato e trasportato nel circolo ematico, dove viene di nuovo ridotto e legato alla transferrina ed alla lattoferrina, tramite le quali raggiunge i tessuti e gli organi target (midollo osseo per la sintesi di emoglobina, tessuto muscolare per la sintesi di mioglobina).
Ogni giorno viene eliminato dal corpo circa 1mg di ferro, tramite vie di eliminazione quali la bile, le feci, le urine, il sangue mestruale, la desquamazione della pelle; piccole quantità di ferro vengono perse giornalmente a livello dell’intestino, principalmente per via dello sfaldamento fisiologico della mucosa intestinale (del quale ripristino è strettamente legato alla buona funzionalità del microbiota intestinale).
La quota di perdita di ferro è maggiore nella donna in età fertile, dal momento che il flusso ematico mestruale causa mediamente una perdita aggiuntiva di circa 0,5 mg/die.
Nonostante gli svariati canali di eliminazione, l’omeostasi del ferro si basa non sulla sua escrezione ma sul controllo del suo assorbimento: la stretta regolazione dell’assorbimento intestinale del ferro rappresenta il meccanismo chiave per il mantenimento della quota marziale corporea; in relazione direttamente proporzionale con il bisogno di sintesi di globuli rossi ed inversamente proporzionale con la quantità presente come riserve organiche.
Il dosaggio completo del ferro nel sangue consiste nella valutazione della sideremia, della ferritinemia, della transferrinemia e dell’indice TIBC.
I parametri biochimici del ferro: valori di laboratorio
La SIDEREMIA
rappresenta la quota del ferro presente nel circolo sanguigno, cioè quello legato alla sua proteina di trasporto, la transferrina; ha una grande variabilità, in base a molteplici fattori legati a età e genere, status fisiopatologico, alimentazione, ritmo circadiano (sono state riscontrate variazioni importanti in base al momento della giornata, fino al 50% nell’arco delle 24h: con pico massimo al mattino e successiva diminuzione nel tardo pomeriggio).
I valori normali sono di circa
70-170 mcg/dL per l’uomo,
50-150 mcg/dL per la donna,
meno del 100mcg/dL nel bambino e nell’anziano
tutti valori soggetti a grandi variazioni; la sideremia aumenta nella donna in gravidanza, per maggior bisogno di ferro immediatamente disponibile nel circolo.
La FERRITINEMIA
rappresenta la quota del ferro immagazzinato all’interno degli organi deputati (fegato, milza, midollo osseo, muscolo scheletrico), quindi legato alla ferritina; è considerato il parametro biochimico più sensibile per evidenziare patologie da carenza o da accumulo di ferro.
I valori normali sono di circa
20-200mcg/L per l’uomo
20-120mcg/L per la donna;
anche in questo caso, vi sono variazioni in base all’età, allo status fisiopatologico, all’alimentazione; nella donna in gravidanza, dal terzo mese in poi, si riscontra una diminuzione fisiologica della ferritinemia, dovuta al bisogno aumentato di ferro immediatamente disponibile.
La TRANSFERRINEMIA
è indice del valore totale circolante della transferrina, che quindi comprende la percentuale della proteina libera (senza ferro, detta anche apotransferrina) e quella della proteina satura (con ferro, in varie proporzioni).
— la transferrina è la principale proteina di trasporto del ferro nel circolo, avendo un ruolo chiave nella sintesi e utilizzo del gruppo eme, necessario per la formazione di emoglobina, mioglobina, citocromi ed enzimi; la frazione di ferro legata a questa proteina è la più dinamica (cioè soggetta ad un turn-over ad alta velocità) di tutto il ferro corporeo.
— il dosaggio della transferrina nel sangue serve a determinare la totale capacità legante di ferro; viene indicato per approfondire le cause di una carenza di ferro, e più in generale insieme agli altri 2 parametri per valutare l’efficacia ed eventuali alterazioni del metabolismo del ferro.
I valori normali variano da 240 a 350mg/dL; si osserva un aumento fisiologico nella donna in gravidanza (soprattutto nell’ultimo trimestre).
Il TIBC (Total Iron Bing Capacity)
rappresenta la capacità totale delle proteine plasmatiche di legare il ferro. Dato che la transferrina è la proteina maggiormente deputata al trasporto di ferro, l’indice TIBC si utilizza per valutare la saturazione della proteina in ferro, ed insieme a questo la sua capacità di riserva (importante ad esempio per la valutazione del processo di ematopoiesi).
I valori normali sono di circa
20-50% nell’uomo
15-50% nella donna
come per gli altri parametri, anche qui si osservano grandi variazioni in base all’età, genere, status fisiologico, alimentazione.
Le analisi del sangue per il ferro sono indicate in diversi scenari clinici sia fisiologici che patologici, come
— lo stato di anemia ( con la valutazione della terapia farmacologica in atto)
— le malattie del sangue (patologie ematiche, deficienze enzimatiche congenite ed a.)
— nell’ambito dello sport: l’attività sportiva agonistica di qualsiasi livello ed a tutte le età (il ferro è cruciale per lo sportivo, dato che la prestazione e la performance sportiva sono dipendenti dal livello di ossigenazione del sangue e dei muscoli)
— per la donna in gravidanza e puerperio
— l’infiammazione cronica tessutale e patologie croniche dell’apparato digerente che possono indurre perdite di ferro per micro-emorragie (gastrite cronica con ulcera, MRGE, Sindrome del colon irritabile-IBS, Sindrome Crohn, Sindrome del leaky gut, ed a.)
— le malattie del metabolismo ed in particolare il diabete: il deficit di ferro è un comune riscontro nei pazienti diabetici (almeno 1 su 5), specialmente in quelli con nefropatia; l’anemia è spesso più severa ed è associata ad un aumentato rischio di complicanze diabetiche (quali l’insufficienza renale e nefropatia, la retinopatia e le malattie macro-vascolari)
— la malattia renale cronica e le disfunzioni endocrine (con cenno particolare alla funzione tiroidea)
Solitamente, insieme alle analisi del sangue per il ferro si esegue anche l’emocromo (l’esame emocromocitometrico con formula-o conta-leucocitaria), con valutazione dell’emoglobina, ematocrito, i valori dei globuli circolanti.
Presso l’Ambulatorio Pelizzo a Udine è possibile effettuare esami ed analisi del sangue per tutti i parametri biochimici indicati dallo specialista (in regime privato o convenzionato-no esenzioni); con prelievo venoso eseguito dall’infermiera professionale ed esecuzione delle analisi presso i Laboratori clinici Bianalisi.
Le analisi del ferro completo fanno parte del Check up Anemia proposto nell’Ambulatorio Pelizzo: il pacchetto di analisi del sangue specifiche per la valutazione dello stato di anemia, è disponibile da lunedì a sabato previa prenotazione.
Nell’approccio dietetico-alimentare per i fabbisogni particolari di nutrizione con riferimento all’introito di ferro, Ambulatorio Pelizzo a Udine pone a disposizione degli utenti la consulenza dietetico-alimentare con il Biologo Nutrizionista: su appuntamento, in orari altamente flessibili e da concordare al momento della prenotazione.
articoli correlati
fonti essenziali
https://www.jamd.it/wp-content/uploads/2017/02/2010_4_4.pdf
msd.manuals.com/carenza di ferro
http://www.plosbiology.org/plosonline/?request=get-document&doi=10.1371%2Fjournal.pbio.0000079
epicentro.iss
researchgate.net
Pelizzo centro infermieristico e prelievi sas di Pelizzo Luigi e Soci.
Via Cividale 292 – 33100,Udine
P.IVA 03123800306 – CF PLZLGU70L24C957E